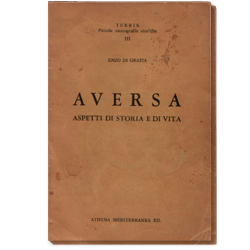Al centro del dibattito politico-sindacale in questi anni la legge Biagi, demonizzata da una parte ed esaltata dall'altra. Al centro delle preoccupazioni delle famiglie in questo periodo l'assenteismo dei docenti: emblematico il caso del professor M., che nonostante trasferimenti, censure, richiami, continua da anni a restare assente “per malattia” mentre al paese natio si occupa dei suoi affari. O quello più recente della professoressa che durante il periodo di malattia è andata a trovare una sorella alle Bahamas. Tutto regolare, ha detto il giudice che l'ha assolta: non era andata in vacanza ma per fare degli esami medici che, sembra, poteva fare solo nelle magiche isole caraibiche. Abbiamo chiesto un parere su questi temi a Valentina Lostorto, esperta di diritto del lavoro e docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle finanze, già magistrato del lavoro presso il Tribunale di Roma.
Al centro del dibattito politico-sindacale in questi anni la legge Biagi, demonizzata da una parte ed esaltata dall'altra. Al centro delle preoccupazioni delle famiglie in questo periodo l'assenteismo dei docenti: emblematico il caso del professor M., che nonostante trasferimenti, censure, richiami, continua da anni a restare assente “per malattia” mentre al paese natio si occupa dei suoi affari. O quello più recente della professoressa che durante il periodo di malattia è andata a trovare una sorella alle Bahamas. Tutto regolare, ha detto il giudice che l'ha assolta: non era andata in vacanza ma per fare degli esami medici che, sembra, poteva fare solo nelle magiche isole caraibiche. Abbiamo chiesto un parere su questi temi a Valentina Lostorto, esperta di diritto del lavoro e docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle finanze, già magistrato del lavoro presso il Tribunale di Roma.
>> >> >> >> >>
Al di là delle inaccettabili esternazioni di Caruso di questa estate, molta parte della sinistra al governo considera la legge Biagi la causa principale dell'abnorme diffusione del precariato. Come valuta queste opinioni?
Tralasciando ovviamente ogni valutazione politica e dando un giudizio esclusivamente di tipo tecnico-giuridico, posso tranquillamente affermare che il cosiddetto precariato è un fenomeno assolutamente indipendente dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (la c.d. legge Biagi).
Nel nostro ordinamento la forma giuridica “normale” per inquadrare le prestazioni lavorative è quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per anni questa è stata l’unica forma tutelata dalle leggi sulla sicurezza del lavoro e previdenziali. L'assoluta rigidità del sistema (solo dagli anni Novanta e soprattutto dal 2000 il nostro legislatore, sulla spinta europea, ha introdotto tutta una serie di istituti improntati ad una maggiore flessibilità del lavoro, quali l’ampliamento delle causali legittime per un contratto a termine o il lavoro interinale) ha purtroppo causato l’utilizzazione in forma elusiva di altre forme contrattuali esistenti nell’ordinamento.
Mi riferisco soprattutto alle famigerate co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), e cioè a forme di lavoro autonomo (e quindi non subordinato) che, per il loro peculiare inserimento nell’organizzazione imprenditoriale del committente, il legislatore all’epoca della riforma del processo del lavoro (1973) ritenne di dover inserire tra quelle meritevoli della tutela processuale riservata alle controversie di lavoro.
Tali figure, ovviamente, essendo pur sempre riconducibili al lavoro autonomo, consentivano (e consentono tutt’oggi con riferimento alla più definita e rigorosa figura delle co.co.pro – collaborazioni a progetto - disciplinate dalla c.d. legge Biagi) al datore di lavoro di “sfuggire” non solo alla pesante obbligazione previdenziale dovuta per i lavoratori subordinati, ma anche alle rigidità organizzative conseguenti all’assunzione definitiva. Basti pensare alle discipline limitative dei licenziamenti, dei trasferimenti, di assegnazione delle mansioni ovvero alla problematica dell’individuazione del numero dei dipendenti, cui spesso consegue l’applicabilità di normative particolarmente vincolanti per i datori di lavoro (come molte norme dello Statuto dei lavoratori o della legge sulla sicurezza del lavoro).
A riprova di ciò è l’alto numero di procedimenti contenziosi davanti alla magistratura del lavoro sin dagli anni ’70 (e quindi ben prima della c.d. legge Biagi) che hanno ad oggetto la natura subordinata o meno di rapporti di lavoro di fatto (lavoro in nero) o contrattualmente qualificati in modo diverso (collaborazioni coordinate e continuative o ancor peggio occasionali).
Uno dei punti più controversi, nell'attuale dibattito sulla riforma del welfare, è il cosiddetto staff leasing, un contratto che peraltro sembra riguardi non più di cinquemila lavoratori e che gli oppositori della legge Biagi vorrebbero abrogare. Cosa pensa di questo proposito? E, più in generale, quali sarebbero, a suo avviso, le conseguenze se si arrivasse a una revisione a largo raggio se non ad una abrogazione della legge?
Più precisamente, gli istituti introdotti dalla c.d. legge Biagi nel 2003 oggetto di proposte abrogative sono il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (anche denominato staff leasing) e il contratto di lavoro intermittente (anche denominato job on call). Si tratta di figure contrattuali del tutto marginali rispetto all’impianto generale della legge, sia sotto il profilo contrattuale (solo ritocchi rispetto alla complessità della riforma, basata sulla rimodulazione del mercato del lavoro e sulla nuova regolamentazione di forme contrattuali “flessibili” quali: la somministrazione a termine, il part-time, il lavoro ripartito, le collaborazioni a progetto) sia sotto quello di effettivo impatto sul mondo del lavoro (i lavoratori coinvolti sarebbero effettivamente poche migliaia).
Chiarito ciò va detto come, a fronte dell’esasperato uso di forme contrattuali “alternative” al lavoro subordinato a tempo indeterminato in chiave assolutamente elusiva rispetto alle normative a tutela del lavoratore subordinato da parte dei datori di lavoro, il tentativo del legislatore del 2003 di dare una regolamentazione normativa anche a forme contrattuali più flessibili (e quindi più adattabili alle esigenze organizzative dell’imprenditore) indicandone limiti e modalità e, sul fronte delle tutele, prevedendo anche per questi lavoratori una copertura assicurativa e previdenziale, rappresenti un passo avanti – e non certo un passo indietro - della lotta al c.d. lavoro nero e all’uso spregiudicato di forme contrattuali alternative.
In altre parole non è certo la regolamentazione di forme di lavoro flessibile a creare il precariato, che è determinato invece dall’eccessiva rigidità del sistema a fronte di un mercato del lavoro sempre più in cerca di flessibilità, anche sull’onda degli orientamenti prevalenti a livello di comunità europea. Né eliminando la legge sul precariato si elimina il lavoro precario.
Il precariato "fisiologico" è però un fenomeno negativo. Come si può combattere?
Si combatte cercando di trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela del lavoratore e le esigenze organizzative dell’impresa, con una regolamentazione - anche in materia previdenziale - chiara e inequivoca che spinga i datori di lavoro a preferire stabilmente la stipulazione di contratti regolari al rischio di assunzioni in nero, attraverso procedure di “emersione” del sommerso non fini a se stesse (sanatorie "una tantum") ma finalizzate ad obiettivi di razionalizzazione del mercato del lavoro di ben più ampio respiro.
L’interprete qualcosa può fare (si può citare la recente sentenza della Corte di cassazione – n.36642/2007 - che ha configurato il reato di estorsione ai danni di un datore di lavoro che aveva costretto alcune lavoratrici a sottostare a condizioni di lavoro vessatorie quali l'assunzione in nero, corrispettivi inferiori alle tariffe contrattuali, mancato godimento di diritti fondamentali come ferie o maggiorazioni per ore di lavoro straordinario, allontanandole dal lavoro in caso di “ribellione”) ma si tratta sempre di interventi sporadici e comunque mai sostitutivi delle politiche del lavoro che devono invece essere meditate e realizzate nelle sedi istituzionali di competenza.
A proposito di assenteismo: sempre la Cassazione ha ordinato la reintegrazione, con diritto alla retribuzione arretrata, di un lavoratore a suo tempo licenziato perché i sistemi di controllo (comprese le telecamere montate per assicurare la sicurezza nel garage aziendale), avevano mostrato frequenti abbandoni non autorizzati del lavoro. Motivazione, l'azienda avrebbe fatto un "uso esasperato" delle nuove tecnologie. Come valuta questa decisione?
Come spesso succede in caso di commenti a pronunce giurisprudenziali, anche in questo caso la notizia “passata” attraverso i media è del tutto fuorviante rispetto alla reale portata del principio affermato dai giudici. Il caso citato riguarda la sentenza della Corte di cassazione n.15892/2007 che ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente Eni che si era reso responsabile di inadempienze e “scoperto” grazie al badge di ingresso nel garage aziendale che consentiva di controllare gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti. In particolare la società, al fine di agevolare i propri dipendenti muniti di autovettura, aveva predisposto per essi un locale garage ove posteggiarla durante l'orario lavorativo, inserendo, tuttavia, un congegno di sicurezza volto a consentire l'ingresso a tale garage solo mediante un meccanismo elettronico attivato da un tesserino magnetico personale assegnato a ciascun dipendente, lo stesso che attivava gli ingressi agli uffici. Oltre a consentire l'elevazione della sbarra di ingresso al garage, il meccanismo rilevava e registrava l'identità di chi passava nonché l'orario del passaggio. Il che permetteva, mediante l'incrocio di tali dati con quelli rilevati elettronicamente all'ingresso degli uffici, di controllare il rispetto o non degli orari di entrata e uscita e presenza sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti.
Peraltro tale apparecchiatura – a differenza di quella analoga installata agli ingressi dell'ufficio – non era stata concordata con le rappresentanze sindacali, né era stata autorizzata dall'Ispettorato del Lavoro, come invece richiede espressamente l'art. 4 della legge n. 300/70, che sancisce la necessità che l'eventuale installazione di impianti ed apparecchiature di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sia in ogni caso preceduta da garanzie procedurali a vari livelli, essendo l'installazione condizionata all'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, ovvero, in difetto, all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
In sostanza il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza non concerne di per sé l’illegittimità di un “uso esasperato” delle tecnologie da parte del datore di lavoro (con la conseguente impunità dei dipendenti controllati in caso di scorrettezze) ma il ben diverso principio che anche un'apparecchiatura predisposta per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile pure in funzione di controllo dell'osservanza da parte di questi dei loro doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro e della stessa correttezza della esecuzione della prestazione lavorativa, costituisce una modalità occulta e insidiosa di controllo che può invadere la dignità e la riservatezza del lavoratore nello svolgimento dell'attività e che come tale può essere installata ed essere legittimamente utilizzata solo nel rispetto delle procedure di cui all’art.4 dello Statuto lavoratori che ho citato poco fa.
In altre parole: non è la tecnologia da bandire ma il suo uso scorretto, e cioè la mancata attivazione delle procedure che la legge prevede per l’installazione dei mezzi di controllo dei lavoratori.
Secondo quanto affermato dallo stesso ministro Nicolais, non sarebbe vero che il nuovo contratto degli statali rende più difficile il licenziamento. Al contrario lo renderebbe più facile, visto che la sospensione può essere irrogata rapidamente, e che due sospensioni portano al licenziamento. Qual è il suo parere? E più in generale, anche alla luce della recente pronuncia di assoluzione dell’insegnante che durante l’assenza per malattia si trovava alle Bahamas, cosa pensa della efficacia del sistema disciplinare nel pubblico impiego?
Il nuovo CCNL relativo al personale del comparto ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 ha modificato parzialmente le norme disciplinari prima in vigore intervenendo sotto vari fronti ed in particolare:
con l’introduzione di una autonoma fattispecie di infrazione disciplinare concernente l’elusione o la manomissione dei sistemi di rilevamento delle presenze, sussistente anche in un solo caso di elusione dei meccanismi di rilevazione della presenza che comporta la sospensione “lunga “ da 11 giorni a 6 mesi, mentre la recidiva comporta il licenziamento.
con l’inasprimento delle sanzioni in caso di atti ingiuriosi, minacciosi o violenti nei confronti dell’utenza o di altri dipendenti;
con la possibilità – prima non prevista dal contratto – di sanzionare il dipendente per comportamenti disciplinari anche se assolto “ perché il fatto non costituisce reato” o formulazioni analoghe, ove ritenuta sussistente la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto;
introducendo la possibilità che il dipendente cautelarmente sospeso nelle more di un procedimento penale (attualmente la sospensione cautelare del dipendente in attesa di giudizio, non può per legge superare i 5 anni, decorsi i quali il dipendente deve essere riammesso in servizio), laddove il reato commesso comporti, sulla base del codice disciplinare, la sanzione del licenziamento, dopo i 5 anni di sospensione già previsti, possa non essere riammesso in servizio quando “l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’amministrazione stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare, comunque, se sospeso rimane tale sino all'esito del procedimento penale.”
In concreto, quale può essere la portata di questa innovazione?
Dobbiamo tener conto che la falsa attestazione sui fogli di presenza o l’elusione dei badge elettronici o dei cartellini marcatempo non erano in precedenza direttamente definiti dal codice disciplinare dei dipendenti dei Ministeri, applicandosi di conseguenza la generale previsione del licenziamento con o senza preavviso in caso di commissione di reati penali o comunque “la commissione in genere – anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche dolosi che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (art.13, 6° comma, lettera d) .
L’attuale norma contrattuale è stata introdotta per ovviare il rischio di impunità dei dipendenti pubblici a fronte dell’orientamento della giurisprudenza penale della Corte di cassazione che ha ritenuto che nel lavoro pubblico privatizzato, il foglio di presenza (come gli ordini di servizio ed altri atti di gestione del personale) non sia più un atto pubblico e quindi, in questo caso specifico, il reato di falso in atto pubblico non sia più rilevabile, con la conseguenza che la fattispecie in esame sarebbe riconducibile esclusivamente al reato di truffa aggravata, integrabile solo solo se i periodi di assenza siano economicamente apprezzabili.
Un passo avanti, quindi, per rendere più snello il procedimento?
Iindubbiamente l'avere espressamente indicato come fattispecie disciplinar-
mente sanzionabile il solo fatto dell’elusione dei sistemi di rilevazione, indipendentemente dalla rilevanza “economicamente apprezzabile” di “atti o comportamenti fraudolenti tesi a conseguire a sé o ad altri un ingiusto vantaggio in danno di terzi” come prevede l’art. 640 del codice penale, può facilitare e rendere più certa l’applicazione della sanzione disciplinare. Tuttavia va anche detto che l'eccessiva “codificazione” delle infrazioni indebolisce di fatto l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro pubblico che oggi ha la possibilità di licenziare il dipendente infedele solo in caso di recidiva, poiché a fronte di una unica contestazione (anche se comprensiva di una pluralità di comportamenti elusivi) il datore può applicare esclusivamente la sanzione della sospensione del servizio fino a un massimo di sei mesi.
Ci sono altri aspetti trascurati sui quali sarebbe importante intervenire?
Da utente del diritto rilevo come per il datore di lavoro pubblico uno dei punti di maggiore criticità enucleatosi in questi ultimi anni attiene alla complessità del procedimento disciplinare (più è complessa e vincolante la procedura più è facile incorrere in vizi che comportano la nullità della sanzione irrogata), procedimento che proprio nei casi più gravi (e cioè collegati a vicende di rilevanza penale) diventa ancora di più difficile gestione.
Mi riferisco alla sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, che comporta il mantenimento in servizio (con relativa erogazione della retribuzione, ridotta ad assegno alimentare solo in caso di sospensione cautelare) anche per lunghissimi periodi di dipendenti indagati, imputati ovvero condannati con sentenza non ancora definitiva, in procedimenti penali. In sostanza l’amministrazione, quando l’illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, deve fare la contestazione degli addebiti – iniziando il procedimento disciplinare - e subito sospendere il procedimento in attesa dell’esito del procedimento penale.
Ciò comporta:
l’assoluta impossibilità per l’amministrazione di agire con immediatezza;
la necessità nei casi più gravi di attivazione di misure cautelari che spesso sono inidonee a tutelare l’amministrazione a fronte dei tempi (a volte lunghissimi) che occorrono per giungere alla conclusione definitiva del procedimento penale, tenuto anche conto della durata massima della sospensione fissata in 5 anni (ben venga dunque la novità del CCNL di cui si è sopra parlato al punto 4) e che vicende intervenute nel rapporto di lavoro (come ad esempio processi di mobilità coatta o volontaria) possono determinare mutamenti nella titolarità del datore di lavoro con grandi difficoltà di gestione del rapporto al momento della riattivazione del procedimento disciplinare, magari a distanza di anni.
Da tutto questo deriva ovviamente un grave danno alla credibilità e quindi al buon andamento dell’amministrazione: basti accennare al fatto che, laddove il dipendente sia stato sospeso e poi non sanzionato disciplinarmente, sorge il delicato problema della restitutio in integrum economica e professionale, con ulteriore danno erariale per l’amministrazione.
Quale potrebbe essere la soluzione?
Forse sarebbe auspicabile sancire una sorta di parallelismo tra procedimento penale e procedimento disciplinare parificandolo al lavoro privato (dove il piano della responsabilità penale è distinto da quello della responsabilità disciplinare, mancando ogni regolamentazione di legge circa i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, con esclusione di ogni effetto sospensivo automatico, a meno che non derivi da espressa fonte contrattuale). Si potrebbe magari “rispolverare” la vecchia previsione dell’art. 117 del Testo Unico n. 3/57 che ancorava l’effetto sospensivo sui giudizi disciplinari in corso all’inizio dell’azione penale (e quindi, per il prevalente orientamento della giustizia amministrativa, solo dopo il rinvio a giudizio, permanendo in capo all’amministrazione il potere disciplinare nel corso delle indagini preliminari, ovviamente sempre per fatti che integrino per se stessi infrazioni disciplinari).
Del resto abbiamo esempi clamorosi di tali criticità come appunto il recente caso – assurto ai clamori della cronaca - di una dipendente che aveva giustificato la sua assenza per malattia con un certificato medico quando poi la visita fiscale aveva accertato che la stessa non era a casa ma alle Bahamas. Nella fattispecie il giudice ha assolto la donna perché il fatto non sussiste, considerando decisiva la produzione di un certificato medico rilasciato da una clinica di Nassau, che attestava che la donna aveva effettivamente eseguito gli accertamenti diagnostici prescritti, anche se in un luogo diverso da quello di lavoro e di residenza. Trattasi di formula assolutoria piena che, qualora diventasse irrevocabile, di fatto bloccherebbe ogni possibile attivazione del potere disciplinare da parte dell’amministrazione, dal momento che il fatto ascrivibile anche disciplinarmente alla dipendente nella specie coincide in pieno con i fatti di cui è stata ritenuta la non sussistenza a seguito di accertamento penale.