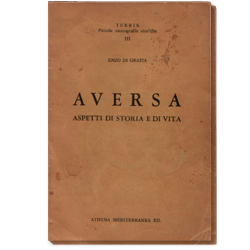1 – Riposto in un cassetto, ho trovato uno scritto difensivo donatomi anni or sono da uno di quei abili avvocati di provincia presso cui spesso si rinserra una saggezza giuridica, invisibile ai più. Si tratta di una memoria di Cassazione, relativa ad una vicenda alquanto singolare per il tema trattato (che qui non interessa).
Rilevante appare – ai fini del discorso che qui tratteggeremo – l’esordio di quello scritto depositato in vista di un’udienza in camera di consiglio, in ragione della manifesta fondatezza del ricorso avversario.
Segnalo al lettore – come cornice di riferimento del racconto – che il ricorso per cassazione era stato particolarmente elaborato (ricco di riferimenti normativi e giurisprudenziali), mentre il controricorso era agile nella struttura, svolto con nonchalance (apparendo al difensore del resistente inconsistente la tesi sviluppata dal ricorrente).
Il ricorso veniva trattato in “camera caritatis” per manifesta fondatezza dello stesso e, in tal guisa, era stata depositata e notificata alle parti la relazione del Consigliere a ciò deputato.
Preoccupato della sottovalutazione dei problèmata che così efficacemente avevano indotto il Consigliere relatore a proporre al Collegio l’accoglimento del ricorso, l’Avvocato del resistente esordiva nella memoria con queste parole: “la difesa della resistente si è avveduta di aver sottovalutato le quaestiones juris oggi al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte: una sorta d’ingenua disattenzione (potrebbe dirsi), che ha trovato il solo conforto nelle meditazioni di Epstein, personaggio chiave in ‘Atlante Occidentale’ di Del Giudice, quando capisce ‘che le cose più importanti avvengono nella distrazione, non nella concentrazione e aveva imparato la necessità di distrarsi’. In questa sede, pur tuttavia, nessuno sarebbe disposto ad offrire generose indulgenze alle distrazioni ed è giusto che si esigano da parte della Suprema Corte attente e corrette argomentazioni da parte degli avvocati (…) che abbiano almeno l’aspirazione prosastica ad attenersi ai valori che Italo Calvino auspicò che fossero preservati nel millennio a venire (purtroppo ciò che accadde dopo la morte del grand homme de pensèe)”.
L’esito del giudizio decretato dalla Corte fu nel senso del rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
2 – Questi pochi righi ci consentono di far partire la breve riflessione sullo stile della scrittura forense.
Cosa ci insegna quell’avvocato di provincia?
Credo, innanzi tutto, che il prologo di quella memoria individui esattamente un maestro della scrittura, che tutti gli avvocati potrebbero assumere come guida nelle narrazioni difensive: Italo Calvino.
Nella sua opera (postuma) ‘Lezioni americane’ – contenente la riproduzione scritta delle sei conversazioni tenute nell’anno 1984 nell’Università di Harvard – l’abile letterato esibisce i cinque canoni del genere letterario (leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità), ai quali ognuno di noi potrebbe far capo nell’esecuzione di un testo scritto: in tal senso anche la letteratura forense è, per l’appunto, letteratura, cioè scrittura còlta a tutti gli effetti, e Giuseppe Capograssi, nelle sue numerose opere filosofico-giuridiche, considera il diritto come scienza strettamente collegata, se non aderente, al vivere quotidiano, essendo una delle forme di pensiero che si esprime attraverso il linguaggio comune.
Un’ulteriore segnalazione merita di essere fatta in ordine agli studi dedicati al linguaggio, svolti dal filosofo inglese Paul Grice, il quale, riportando alla superficie le categorie kantiane, elabora le cosiddette ‘massime conversazionali’ per mezzo di quattro punti fondamentali, riguardanti il conversare fra individui
1 – Quantità: “fornisci la dose necessaria di informazione, né troppa né troppo poca”;
2 – Qualità: “sii sincero fornendo informazioni vere sulla base di ciò che sai”
3 – Relazione: “cerca di essere pertinente il più possibile, seguendo un percorso basato sul ragionamento logico;
4 – Modalità: “sii chiaro, esprimendoti in modo attinente e non ambiguo”.
3 – Da questo momento in avanti la nostra attenzione sarà concentrata sugli scritti difensivi civilistici (ma il discorso non cambierebbe di molto per quelli di natura penale, amministrativa, tributaria etc.) e, in tal guisa, credo che gli Avvocati dovrebbero essere pervasi dal sentimento della leggerezza, che consiste nel “togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio” (Calv. p. 5) : “una leggerezza della pensosità”, diversa e opposta alla “leggerezza della frivolezza”; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e opaca” (Calvino, op. cit.12). La leggerezza di cui qui si parla non è genericità o, peggio, superficialità, ma è un composto che “si associa con la precisazione e la determinazione, non con la vaghezza o l’abbandono al caso” (Calvino, p. 17, Lezioni americane, Mondadori, 2000); una sorta di ‘semplicità’ di sottofondo, dunque, data dalla capacità di rendere sobrio anche ciò che ha una natura intrinsecamente complessa; in tal senso si segnala una massima molto attinente di Gustave Flaubert quando afferma che “il vero problema dello scrivere non è tanto di sapere ciò che dobbiamo mettere nella pagina, ma ciò che da questa dobbiamo togliere”. Mi sembra che, seguendo questo canone, si ha un buon inizio letterario, perché si ben predispone l’animo e la mente del giudice, che della controversia è l’arbitro imparziale, saggio e, talvolta, còlto: sul versante giudiziario, l’ultima parola spetta, per fortuna degli abitatori del mondo pratico, alla Corte di Cassazione, appunto detta Suprema, ché non solo dice qual è il diritto esatto, applicabile al caso, ma deve svolgere (si potrebbe osare di dire) tutti gli sforzi tecnici in vista della realizzazione del valore ultimo del processo: la Giustizia.
Così si esprime il dato normativo che trova il suo proprium nella proposizione sintattica nell’enunciato di cui all’articolo 24 (Costituzione), il quale -nell’asserire che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” – consacra la Giustizia quale valore fondamentale che deve ispirare e guidare tutto l’Ordinamento giuridico, in ogni suo manifestarsi: ciò è tanto vero che il testo costituzionale, poco più avanti, sottolinea come il valore del “giusto”, di cui si sta discorrendo, è amministrato in nome del popolo e per mano di un organismo appositamente istituito, ovverosia la Magistratura, collocata in una (non casuale) posizione di autonomia ed indipendenza da ogni altro potere. In tale senso è improntato tutto l’apparato normativo previsto del Regio Decreto risalente al 1941, istitutivo dell’Ordinamento Giudiziario, che è dato dall’insieme di princìpi, regole e procedure che governano il potere giudiziario.
Questo medesimo valore (la Giustizia) pervade l’Avvocatura (come professione e come ceto) e, in tal senso, deponeva il già abrogato (dal CNF) preambolo del Codice deontologico forense il quale – nell’affermare che “l’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia” – creava un ponte di coerenza fra l’attività difensiva e i princìpi, derivati dai valori, che ispirano l’ordinamento giuridico, la stessa comunità e, in modo ancor più primordiale, l’umano vivere.
Leggerezza è valore e i valori (come le clausole generali) non si lasciano scolpire sulla pietra; il linguaggio può solo tentare di lambirne i contorni, di tratteggiare i chiaroscuri, di mettere in luce le ombre e di mettere in ombra il fulgore, di definirla in negativo, senza comunque riuscire ad entrare nel “centro di gravità permanente”, perché lì c’è il mistero e, dove v’è mistero, deve calare il silenzio. Ciò che è certo è che il valore di la Giustizia è dato assiomatico e, come tale, (per dirla con i matematici) non deve essere dimostrato, perché x=x.
L’assioma, infatti, per essere tale non è mai lambito dal dubbio e, nel caso di specie, la Giustizia è dogma di fede e qualsiasi piccolo dubbio ne distruggerebbe, d’un sol tratto, il mistero, su cui vi sono pagine memorabili di Salvatore Satta.
Il tema della Giustizia da Nicolò Lipari, il quale dice: “è (…) ricorrente l’affermazione che nel nostro Paese la giustizia sia mortificata e umiliata. (…) Nella prospettiva qui proposta la giustizia viene pensata non in una sua astratta dimensione filosofica, ma esclusivamente come predicato necessario del diritto, come condizione ineludibile del valere del diritto come valore” (N.L., Perché in Italia non si crede più nella giustizia, in Studium, 2014).
4 – La rapidità è un altro canone fondamentale della letteratura forense e giudiziaria.
La rapidità nello scrivere vuol dire:
a) non perdere tempo con se stesso;
b) non farlo perdere al giudice e all’avversario.
4.1- Il secondo aspetto è il più agevole da descrivere, perché affonda le sue radici innanzitutto nell’educazione e nel rispetto dell’altrui ruolo: scrivere una difesa farraginosa e inutilmente complessa significa imporre un grado di attenzione non proporzionato a ciò che più semplicemente la narrazione dovrebbe descrivere. Del resto vi sono visibili insofferenze verso gli scritti “liturgici” che esprimono in cento pagine ciò che potrebbe essere contenuto in cinque: “un’altra tendenza degli avvocati civilisti è di affidare le loro argomentazioni difensive a un periodare molto lungo, infoltito da precisazioni pleonastiche ed espressioni ridondanti, tributarie di vezzi linguistici sedimentati nel corso del tempo” (G. Conte, Il linguaggio della difesa civile, in Lingua e diritto a cura di A. Mariani Marini e F. Bambi, Pisa, University Press, 2013, p. 44).
Si badi bene ad un dettaglio non trascurabile: la brevitas di cui qui si discorre, deve poggiare sull’abundantia scientiae, atta a creare stabilità, solidità, compattezza e completezza all’elaborato finale: parliamo della “sintesi”, che non deve tramutarsi in discorso claudicante, incompleto o carente, bensì sapiente e partecipato.
Non voglio essere riduttivo e capisco che vi sono momenti difensivi che richiedono ben più (anche) di cento pagine: quando ciò accada, ci si deve chiedere quanta materia inutile occorre eliminare, prima di licenziare il testo; rilevante è il proposito ogni volta che si scrive qualcosa di contenere nei minimi termini (generalmente bastano, per esperienza, venti pagine) lo scritto che per avventura occorre redigere.
4.2- Più complessa è l’esigenza per un avvocato di “non perdere tempo”.
Sotto questo angolo riflessivo, il ceto forense si trova tra Scilla e Cariddi: non essere superficiale da un lato, ma essere rapido nell’esecuzione del testo (dopo aver pensato).
Il pensiero giuridico si articola in una serie di passaggi che si lasciano raccontare, scanditi in tre passaggi: leggere (la sentenza da impugnare, lo scritto avversario cui replicare), ascoltare la parte, studiare i testi dei dottori della legge, scrutinare la giurisprudenza; attraverso questi passaggi fattuali nasce l’elaborazione del pensiero (tracciato su carta).
Questo è il lavoro di base (reale) su cui s’innesta un quid immateriale della mente: l’intuito giuridico, qualità che hanno “quasi” tutti gli avvocati e che si distribuisce per quantità ineguali, svolgendo qui “la natura” un ruolo aristocratico selettivo (non condizionabile da influenze sconvenienti).
Orbene il lavoro qui descritto richiede un tempo incomprimibile e la sua ampiezza dipende dal grado di perfettibilità che si vuole raggiungere nella redazione di uno scritto e dalle capacità che lo scrittore ha nell’esecuzione di ciò che la sua mente è stata capace di elaborare.
Ciò che può dirsi certo è che l’esecuzione dell’opus deve essere rapida, perché – come dice Calvino – “più tempo risparmiamo, più tempo potremo perdere” e, come ognuno sa, “il tempo è la ricchezza di cui siamo avari” (Calvino, op. cit., p. 45).
Questo ultimo concetto viene descritto da Calvino con una storiella che merita di essere riproposta al lettore: “tra le molte virtù di Chuang-Tzu c’era l’abilità nel disegno. Il re gli chiese il disegno di un granchio. Chuang-Tzu disse che aveva bisogno di cinque anni di tempo e d’una villa con dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora cominciato. ‘Ho bisogno di altri cinque anni’ disse Chuang-Tzu. Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si fosse mai visto” (I. Calvino, Lezioni americane, Mondadori, 2000, p. 62).
Ora qui mi fermo sulla narrazione delle Lezioni americane, perché non vorrei che mi venisse mosso anche il rimprovero di ripetere ciò che altri hanno così bene affabulato; aggiungo solo una notazione finale riferita alla chiarezza. Il quesito che qui mi pongo è se la ‘chiarezza’ segue o precede la ‘rapidità’: si riesce ad esser chiari poiché si è stati rapidi, o si è rapidi perché v’è chiarezza a monte? Ebbene, credo che non sia possibile essere agili e veloci se di fondo non c’è limpidezza: una trasparenza in grado di eliminare i possibili equivoci accaduti o potenzialmente accadibili.
A conclusione di quest’ultimo discorso e con un’utile funzione di riepilogo, mi limito a richiamare la formula del filosofo greco Demetrio quando dice: “non dire poche cose con molte parole, ma molte cose con poche parole”.
5 – Vorrei invece, nello scenario conclusivo di questo scritto, svolgere due cenni: a) sull’arte dello scrivere di diritto; b) e sulla cultura necessaria per scriverne.
5.1- Come si riconosce universalmente, lo scritto difensivo s’incentra sul modo di argomentare che, prima di essere tale, passa dalla scienza dell’argomentazione (scienza come technè, di cui gli Avvocati italiani possono dirsi maestri, per una semplice ragione, perché la loro mobilità di pensiero si radica nel senso proprio del termine “radice” nella cultura del mondo greco – romano); il riferimento, in verità, si aggancia ad un ben più ampio concetto legato alla lunga disquisizione sulla dialettica, intesa propriamente come arte dialogica, affrontata da molti filosofi a partire da Parmenide e Zenone di Elea. Per Aristotele, inoltre, l’arte del dialogare si lega strettamente al concetto di opinione probabile ossia ad un iter che poggia le basi proprie su un ragionamento ‘umano’ (e quindi fallibile per definizione). Collegato al pensiero di Aristotele è quello di Hegel in merito alla dialettica vista come strumento per raggiungere la verità, in un processo articolato in tre tappe: Hegel pone in stretto collegamento “dialettica e verità”, elaborando un iter dinamico in tre momenti: tesi (l’essere delle cose per come esse appaiono essere) antitesi (ciò che è diverso e si contrappone all’essere) e sintesi (l’unione e la composizione dell’essere e del non essere, e cioè dei due elementi in contraddizione); attraverso il passaggio finale, ovvero la sintesi, si giunge ad un divenire che vuole, in verità, tramutare l’originaria negazione espressa dal non-essere (antitesi) in affermazione dell’essere (tesi).
Coloro che hanno letto alcune opere di Aristotele (‘La Metafisica’, ‘Ethica Nicomachea’, ‘De interpretazione’, ‘De generatione et corruptione’) o di Cicerone (‘De Oratore’, ‘De senectute’, ‘De amicitia’, ‘De officiis’), si rendono conto che le loro pagine (inconsapevolmente o consapevolmente) soggiacciono a regole che ormai fanno parte di un bagaglio culturale “innato” (perché ereditato dai padri del pensiero). L’inconsapevolezza svanisce per chi, dalle letture dei classici del pensiero occidentale, abbia tratto i canoni logici, che guidano la penna nella trattazione degli argomenti. Vengono così alla luce vere e proprie opere scientifiche sull’argomentazione, quali quelle – per citarne solo alcune – di Roland Barthes (‘Il grado zero della scrittura’, ‘Il piacere del testo’, ‘Variazioni sulla scrittura’) nonché di Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (‘Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica.’).
L’argomentazione diviene “arte” solo quando lo scrittore abbia il dominio delle parole e delle regole per metterle insieme: allora si giunge ad un più alto livello di espressione del pensiero, che è meritevole di essere ascoltato o letto.
Qual è lo scopo che lo scritto difensivo dovrebbe perseguire?
La risposta corrente a questa domanda pare essere condensata nella seguente perifrasi: l’argomentare deve persuadere il destinatario del messaggio (nel caso del diritto, il giudice).
L’assunto non è un assioma o, meglio, lo può divenire solo a condizione che si connoti di contenuti ben più specifici, che non sono rappresentate solo dalle le regole tecniche del lessico giuridico.
E’ risaputo che l’enunciato della norma è soltanto il punto di partenza del ragionamento giuridico, non l’approdo. Quest’ultimo è il risultato dell’utilizzo di altre norme sull’interpretazione (anch’esse da interpretare), della valorizzazione dei principi e del rispetto dei valori. Dei valori si può indicare ove poterli rintracciare: per il nostro ordinamento, i loci sono costituiti dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza e dalla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali.
Codesta cornice di riferimento normativo consente di poter dire quale sia il fine (persuasivo) dell’oratore come dello scrittore (di diritto); prima però una precisazione: l’attività oratoria e la scrittura fanno parte del genus loquendi; più nello specifico, si potrebbe dire, con le parole dello scrittore e aforista francese Jules Renard, che “scrivere è un modo di parlare senza essere interrotto”.
* * *
Ebbene, qual è il fine ‘giuridico’ di questo parlare?
Non può essere il mero convincere il giudice: ciò si desume irrefutabilmente dalla schietta constatazione che tutti rifiuterebbero di credere che sia un “valore” il fenomeno (del tutto accidentale) di convincere qualcuno con argomenti falsi, o peggio insulsi, o peggio ancora disadattati e patologici.
Se questo può dirsi un assioma in negativo (-α≠α), allora dovremmo essere certi che l’arte della persuasione, propriamente detta, deve contenere un nucleo stabile per essere finalizzato alla realizzazione di un dogma, quello della “Giustizia”.
Quest’ultima abbraccia e coinvolge, in prima linea, i Giudici, perché essi ne sono i servi (servi legis sumus quia iustitia fiat). La conferma di diritto positivo dell’enunciazione si ricava dagli atti normativi più sopra richiamati (art.24 Cost.), dal complesso normativo previsto dall’Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e dal Preambolo del Codice deontologico forense (nella versione abrogata).
5.2 – Per ciò che concerne la qualità di uno scritto, è forse facilmente deducibile ciò che determina il discrimemen tra un elaborato esaustivo, ricco e circostanziato, rispetto ad altro incompleto, carente ed impreciso: conoscenza e cultura sono gli elementi necessari e non eliminabili per dare alla luce un prodotto di qualità; anzi, più precisamente, è l’elemento culturale che pone le basi per parlare di arte dello scrivere: efficace è l’aforisma di Goethe secondo cui, “se sai leggere devi capire; se sai scrivere devi sapere qualcosa”.
Il termine “cultura” abbraccia diversi concetti: cultura significa, anzitutto, padronanza della sintassi e della grammatica italiana; significa altresì conoscenza del significato esatto delle parole ed uso corretto delle stesse (si pensi alla differenza di significato che intercorre tra paura e timore, ira e severità, grazia e miracolo, saggezza e sapienza, ironia e autoironia, tutti affini, ma non identici); significa conoscenza tecnica dell’ancor più specifico linguaggio giuridico; significa, ancora, conoscenza della storicizzazione dei concetti di diritto. In tale prospettiva, il pensiero corre ad un lavoro di Aurelio Gentili in merito ad una conoscenza che deve necessariamente abbracciare tutto il diritto per potersi accennare ad un concetto di diritto che possa assumere sembianze culturali, dove conoscenza significa storia, anatomia, motivazione ed evoluzione del diritto; un sapere giuridico legato al solo passato storico significherebbe percorrere quelle “strade del quartiere in cui viviamo: sono note e rassicuranti, ma non portano lontano”. (A. Gentili, Il diritto come discorso, Giuffrè Editore, 2013, p. 131).
Entra qui in gioco anche il discorso legato all’attività di interpretazione del dato normativo: basti pensare all’opera interpretativa gravante sull’avvocato nel momento in cui si trova dinanzi ad un problema pratico risolvibile attraverso il modellamento della fattispecie concreta su quella astratta (prevista dal legislatore) e viceversa. Quest’ultima tipologia sussuntiva è attività di produzione che risponde ugualmente, come accade nel caso dello scienziato ‘puro’ di diritto, all’interrogativo inerente il quid juris, solo attraverso una modalità differente chepassa attraverso un dato puramente pratico, per giungere ad un astrattismo, ad un dato teorico; ecco che ha senso citare la distinzione fra scienza giuridica e prassi forense, distinzione che viene sinteticamente descritta come segue: “la supremazia della scienza giuridica sulla prassi forense nell’opinione corrente è sempre consistita in questo: l’avvocato fornisce soluzioni furbe, lo scienziato soluzioni giuste”. (Gentili, op. cit., p. 168).
La cultura può abbracciare anche àmbiti del sapere diversi rispetto a quelli legati in modo diretto al mondo del diritto e così anche una buona conoscenza della filosofia rende possibile l’uso di questa fonte del sapere per fini di diritto e di giustizia; così dicasi anche per l’economia, la sociologia e, perché no, anche la matematica e la logica matematica possono svolgere questa funzione di integrazione ed arricchimento in particolare per quel che concerne in chiave di esattezza della soluzione giuridica.
6 – E dunque, cosa serve all’argomentazione perché persuada della fondatezza della ragione del diritto che si postula in giudizio?
L’instrumentum è costituito dalla verità; la verità (αλή εια) che nel pensiero greco antico si soleva distinguere dall’opinione (δόξα), sulla scia delle riflessioni condotte da Parmenide, il quale soleva riporre piena fiducia su di un sapere desunto completamente dalla ragione anziché dai sensi.
Orbene sul valore di verità non sono poche le riflessioni da svolgere ed emblematico, in tal senso, è il libro di Michele Taruffo (La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti), di cui si riportano di seguito alcuni significativi brani: “ogni enunciato relativo ad accadimenti del mondo reale è vero o è falso in sé in funzione dell’esistenza di questi accadimenti nel mondo reale. In sostanza, è la realtà a determinare la verità o la falsità delle narrazioni che la descrivono. (…) Il punto essenziale è che ogni enunciato fattuale è vero o falso in sé, in funzione dell’esistenza o inesistenza dell’evento che descrive. (…) la realtà esterna esiste e costituisce il metro di misura (…) che determina la verità o la falsità degli enunciati che se ne occupano. (p. 78) (…) la verità di un enunciato è determinata dalla realtà degli accadimenti che quell’enunciato descrive. Se così non fosse (…) si giungerebbe alla conclusione paradossale che vi sarebbero infiniti concetti di verità, tutti sostanzialmente equivalenti” (M. Taruffo, La semplice verità, Editori Laterza, p. 81, 2009)
La conquista della verità in ambito processuale è sinonimo di Giustizia, laddove “la giustizia, come la verità (…) si lascia intravedere quando il pensiero e il linguaggio si aprono a una riflessione profonda e onesta, stimolata (…) dal pensiero e dal linguaggio che la Letteratura sa mettere a disposizione” (AA.VV., Giustizia e Letteratura I, Vita e Pensiero Editori, 2012, p. XXXVI): una soluzione giuridica corretta, assunta secondo diritto, è, in effetti, anche una decisione vera e giusta, sorretta dalla massima richiamata da Luigi Ferrajoli: “veritas non auctoritas facit iudicium” (L. Ferrajoli, Principia iuris, Laterza-Bari, 2007, p.876); ciò è confermato anche da Benedetto Croce quando scrive che “la verità (…) è la madre della giustizia” ed “è, nella ricerca, a capo della scala degli errori (…) Ricercare vale, insomma, percorrere la scala degli errori”. (B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, Laterza-Bari, 1981, pp. 275-278).
* * *
Ci si potrebbe a questo punto porre una domanda ulteriore: che cos’è la verità per l’avvocato? La verità suppone (a monte) una “buona volontà”, umile ma non pigra, che nella sua laboriosa operosità voglia approssimarsi alla conoscenza del dato nella sua umanità fenomenica; è insomma la metodica conoscitiva che utilizza gran parte dell’Avvocatura nel condurre le battaglie processuali. Riflettendo su questo ruolo (quello di avvocato) ci si rende conto che il compito di questi è di ricostruire i fatti nella prospettiva della parte ed in ciò è il senso dell’esercizio effettivo della difesa del cliente.
* * *
Viene allora da domandarsi qual è l’obiettivo cui deve tendere il difensore? È quello del raggiungere la verità?
L’avvocato deve, certamente, svolgere la propria funzione di tutore degli interessi del soggetto che si affida alle sue cure, con l’ausilio di un filtro fondamentale, ovvero la capacità di critica, sinonimo di consapevolezza.
Ciò detto, però, si faccia attenzione ad un dato importante: l’avvocato non si tramuta mai in un freddo inquisitore che intende giungere al vero costi quel che costi, ma deve rimanere “confessore” della parte, il che implica che egli tenderà sempre a palesare le verità che la parte vuole rivelare: tanto è vero che l’avvocato non è obbligato a dire la verità ed il suo ruolo nulla ha a che vedere con quello di testimone, il quale invece, giura di dichiarare il vero; l’avvocato è, viceversa, vincolato al segreto e il suo obiettivo è quello di tutelare interessi e diritti (a volte anche fondamentali) del cittadino, in ragione della faziosità istituzionale, anzi costituzionale (art. 24 Cost.), che gli è propria. Quanto appena detto non vuole dirottare verso mete pericolose ed errate: all’avvocato è fatto divieto di alterare la verità fattuale e ciò è detto a chiare lettere da Franco Cipriani: “per gli avvocati, ‘imbrogliare le carte non significa e non può significare barare o mentire, bensì, più semplicemente, metterle in un ordine che possa tornare utile al proprio cliente” (F. Cipriani, L’avvocato e la Verità, in Rivista ‘La previdenza forense’, 2003, n. 3, p. 223).
In conclusione l’avvocato si limita a svelare la verità della parte, verità che potrà essere oggetto di conferma o smentita da parte del giudice, il quale tenta il recupero di una verità oggettiva, terza, completa, imparziale e neutrale, sulla base, naturalmente, del materiale fornito dagli avvocati (mai attraverso una ricerca autonoma), operando scelte destinate ad assumere il ruolo di protagonista sulla scena processuale.
Si potrebbe a questo punto credere che la verità rivelata dal giudice sia assoluta, dimenticando, erroneamente ed ingenuamente, che di verità assoluta non è possibile parlare nella nostra realtà umana (relativa e perciò limitata) e chissà che non sia una fortuna trattandosi di ‘entità’ (la verità stessa) da utilizzarsi con molta prudenza: Jorge Luis Borges ci invita a “non esagerare il culto della verità: non c’è uomo che alla fine d’una giornata non abbia mentito, a ragione, molte volte”. (J. L. Borges, Elogio dell’ombra, Einaudi-Torino, 1998, p.101 da Frammenti di un Vangelo apocrifo). Da questi passaggi affrettati, sembra possa dirsi che la fisionomia della verità cambia di aspetto: è, per l’avvocato più strumento che valore (da perseguire), strumento che si pone in posizione subordinata rispetto al diritto che da mezzo assume le sembianze di valore.
Il discorso potrebbe inoltre cadere, quasi in una successione logica, in un campo di riflessione più ampio, che spezza il perimetro meramente processuale, travalicando il limite segnato dalle mura di un’aula di tribunale: viene in considerazione il rapporto intercorrente tra verità e regime democratico (vigente nel nostro ordinamento); democrazia vista quale presupposto necessario per discutere di quella ‘fiducia’ che il cittadino dovrebbe riporre in uno Stato di diritto, fiducia che si rintraccia nella professione forense, essendo quest’ultima uno degli specchi nei quali è possibile scorgere l’immagine fedele, in quanto riflessa, di quella stessa democrazia presupposta. In tal senso si torna al discorso sulla littera forensis e allo stile comprensibile e fluido che essa deve mantenere vivo, proprio per il tipo di attività svolta dall’avvocato stesso: tutela, lavoro di riflessione in molti casi estremamente meticoloso, risoluzione di cavilli giuridici; senza contare gli indesiderati eventi che possono abbinarsi per una giustificabile carenza di sonno! L’avvocato quindi è sciolto dall’obbligo di verità, perché il giuramento che egli presta è quello di esercitare i doveri professionali con lealtà, onestà e decoro nell’interesse della giustizia, sempre, però, nell’ottica della parzialità della parte; nella professione forense l’obbligo del segreto non è semplicemente un obbligo, ma si erge su di un gradino più elevato, acquisendo identità di valore: il segreto, anzi, diviene ‘valore dei valori’ essendo un bacino contenente le verità, ed ecco perché si è parlato della verità come strumento. Il segreto è un valore-dovere (forense), non un privilegio spettante ad una minoranza; esso è un peso onerosissimo che grava sull’Avvocatura e serve a proteggere il bene più alto della persona: il valore della libertà di coscienza.
* * *
Altra domanda: cosa sta a significare la norma deontologica contenuta nell’art. 14 del Codice Deontologico Forense titolato ‘dovere di verità’? La norma, come balza all’evidenza, non parla mai di obbligo ma di dovere: qual è la differenza? Sfogliando in particolare L’enciclopedia del diritto, ci si rende ben conto dell’esistenza, nella realtà giuridica, di situazioni nelle quali diritto e obbligo non si presentano come due diverse ed opposte facce della stessa medaglia, bensì come due facce, meglio due aspetti, della medesima medaglia e l’esempio, in quest’ultimo caso, è dato dalla categoria dei ‘poteri-doveri’; il cosiddetto obbligo risulta essere ‘estrazione’ proveniente da una miniera ben più ampia, data dalla vasta categoria del dovere, nel momento in cui viene a sussistere una bilateralità, una prestazione ed una controprestazione, un particolarismo ed una relatività. Il dovere ha una sua connotazione assoluta in quanto individua una posizione (quella di dovere appunto) che non è collegata ad una relazione intersoggettiva, ma che ha, per così dire, valenza di per se stessa, in questo modo dando, ad esempio, peso ed identità al proprietario di un appartamento per il solo fatto di esserne tale; viceversa l’obbligo, come poc’anzi si accennava, si posiziona sempre in una relazione di rapporto particolare ed assume, quindi, un carattere relativo e cioè valevole e spendibile nei soli confronti (ad esempio) di colui il quale è obbligato a pagare in virtù di un contratto di compravendita. Il dovere è dunque ben più “alto” dell’obbligo, riferendosi alla generalità dei consociati o meglio alla realtà statale nella sua interezza e collegandosi, in un certo senso, ai concetti di eticità e moralità di una condotta, inserita in un contesto regolamentato: un’etica ed una morale secondo diritto.
Ciò che traccia il suddetto art. 14 è una regola ‘estetica’, che non impone il dovere incondizionato di svelare la verità (al giudice o ai terzi); è regola di forma e di stile, tesa ad impedire che siano contraddetti dati oggettivi evidenti, il canone non fa riferimento ad un concetto di verità, per così dire, ‘particolare’ bensì ad una verità più ‘generale’, di atteggiamento generale, comprensiva dei concetti di dignità, di correttezza, di lealtà, perché: non smentendo i fatti obiettivi ed osteggiando la tentazione ad introdurre prove false, gli avvocati tutelano la dignità del ceto e, in ultima istanza, perseguono l’interesse superiore della giustizia.
La verità semmai ha un altro ruolo nella vita degli attori del processo; in effetti, avvocati e giudici, sono sottoposti, nella loro quotidiana opera, al giudizio di verità che un tribunale superiore applica in ogni istante della loro vita: è il tribunale silente della coscienza che, quando si attiva, è inesorabilmente giusto e crudele nel suo giudizio.
Esiste un legame importante, sul quale vorrei di seguito continuare a soffermarmi, in grado di raccontare la storia e di disegnare la fisionomia di ciò che si suole definire con il termine ‘giuridico’: mi riferisco al rapporto sussistente fra letteratura e diritto; tra questi due emisferi v’è un collegamento intimo dato dal linguaggio e dal terreno sul quale il linguaggio si muove: due sponde di uno stesso fiume destinate ad una confluenza. Qui si riallaccia il discorso sul diritto come letteratura, sulla natura etica del diritto e sulla fisionomia umana di ciò che chiamiamo ‘giuridico’: verrebbe da parlare di pieghe letterarie del diritto e di pieghe giuridiche della cultura e del sapere (Antonio D’Amato scrive de ‘La letteratura e la vita nel diritto’ nel 1936 definendo queste due realtà come branche “dell’attività dello spirito”: A. D’Amato, La letteratura e la vita nel diritto, Ubezzi & Dones editore, 1936, p. 14). La letteratura d’un tempo era pervasa dall’elemento giuridico e ciò è giustificato dal fatto che l’ambiente culturale (nei secoli?) aveva uno stampo marcatamente giuridico. La presenza ‘di diritto del diritto’ si riscontra nelle opere di Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Carlo Goldoni, per rimanere nell’ambito italico, ma se volgessimo lo sguardo oltreconfine potremmo citare Shakespeare, Kafka, Omero, Goethe, Dickens, Dostoevskij, Tolstoj.
II
Ciò detto, è bene a questo punto parlare del linguaggio più specifico utilizzato nel mondo del diritto: come si conforma il tecnicismo giuridico a quanto scritto sino ad ora? La risposta sta nel riconoscere un elemento innegabile dato dal fatto che ciascun ambito del sapere tecnico mantiene al suo interno un ‘codice linguistico’; ciò vale per qualsiasi àmbito: giuridico, medico o filosofico che sia. Nel nostro campo si discorre di diritto (ius dicere) e parlare, ad esempio, di un contratto con il quale “una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” significa parlare, con una parola, di ‘appalto’; questo è il termine tecnico che consente, fra operatori del diritto, di sintetizzare con un solo vocabolo ciò che, tuttavia, è spiegato nell’articolo 1655 c.c. con un linguaggio coerente con quanto elaborato nel presente scritto. E’ come se dicessimo che in un ambito scientifico specifico esiste un contenuto (il linguaggio comune) ed un contenitore: quest’ultimo è dato proprio dal linguaggio tecnico; questi due elementi, meglio atteggiamenti, entrano in rapporto diretto con il tipo di interlocutore che si pone innanzi, ad esempio, all’avvocato: l’ambito processuale necessita del tecnicismo tipico di questo ambiente. Attenzione però, linguaggio tecnico non significa impossibilità di accesso ad un discorso, ma semplicemente saper chiamare le cose con il proprio nome: in questo caso trattasi di nomen iuris.
Volendo ricapitolare, l’argomentare dell’avvocato, scritto oppure orale, dovrebbe possedere sembianze e sostanza di un testo piacevolmente leggibile o auscultabile. Il linguaggio, nel dinamismo giuridico, è elemento fondamentale essendo il vettore principale attraverso il quale si svolge tutta l’attività forense. Il giurista lavora per mezzo di un ragionare che si situa alla base del vettore principale, se non esclusivo, ossia l’eloquio; ebbene il linguaggio giuridico ha un’impronta di carattere principalmente sociale perché risolve e analizza i problemi presenti in un contesto di vita in comunità o, ancor più semplicemente, popolare: ciò è tanto vero che la disciplina che regola la professione forense (L. 247/2012) parla in modo inequivocabile, all’art. 1 comma 2 lettera c, di “affidamento della collettività” nelle mani del professionista avvocato; di qui, si diceva, il linguaggio tecnico giuridico utilizzato, in un certo senso, per rimodellare la realtà, per darne una traduzione sublimata per com’essa dovrebbe essere secondo diritto: proprio a questo scopo è servente la rinomata ficito iuris. La citata disposizione di legge parla anche (art. 3, comma 1) di “giudizio intellettuale” impensabile senza un iter logico, un ragionamento che deve essere alla base dell’argomentazione finale; iter logico, come si diceva, libero ed indipendente ma, nello stesso tempo, non arbitrario bensì vincolato da “lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza” (art. 3, comma 2).
Alla luce delle regole e degli ‘auspìci’ sin qui analizzati, il ragionare giuridicamente, alla base della scrittura e della parola, implica, dunque, un’attività di ricerca nozionistica destinata a risolversi in attività creativa, il cui risultato finale è dato da un prodotto di novità se frutto di una ricerca critica, meditata, emotivamente neutrale ma non passiva.
Il fatto di mantenere vive ed effettive queste regole nell’attività di avvocato è, inoltre, potenzialmente in grado di innescare una reazione a catena, data dalla ripercussione in positivo che questi elementi esercitano sull’andamento complessivo del processo.
La genuinità, se così può dirsi, di un testo, non esclude, naturalmente, un’eleganza di stile e di forma in grado di accompagnare, ed anzi rendere ancor più gradevole, il componimento verbale oggetto di lettura o di ascolto; ciò è dimostrabile attraverso la citazione, ancora una volta, di quella memoria difensiva menzionata all’inizio del presente lavoro: la ‘leggera eleganza’ e la ‘chiarezza ricercata’ di quell’avvocato di provincia, ha dunque svolto il ruolo di ‘custode’ del pensiero, accompagnandone l’apertura ed anche la chiusura.
III
Credo che il diritto rechi con sé la qualità del “perfettibile” – non della “perfezione”, che non esiste in nessuna scienza, nemmeno nella matematica, in cui, ultimo approdo, Goëdel elabora il teorema d’incompletezza – volendo con ciò dire che ad un caso controverso (fattispecie astratta o concreta) si può dare una soluzione sola, quella giusta: questo, che potrebbe apparire un dogma di fede o un apriorismo logico, è ciò che si trae dagli affari del mondo (“the things of affairs”), dalla prassi, dall’esperienza. Le stesse sentenze della Cassazione – chiamate a tracciare “il diritto vivente” – presentano, come si dice nel gergo, indirizzi opposti, ma l’opposizione è solo apparenza perché dei due indirizzi, uno è errato, l’altro è esatto: quello errato non vale nulla; la contrapposizione non esiste perché -@ <@. Sul piano ordinamentale è inconfutabile dato che si rinviene il c.d. principio nomofilattico (una sola soluzione è vera e possibile), monopolio esclusivo della Suprema Corte che assicura l’esatta interpretazione della norma.
* * *
In definitiva può azzardarsi – ma l’azzardo è protetto da una scuola di pensiero la cui autorevolezza non è messa in discussione – che il ragionamento giuridico ha fondamenti matematici non solo perché la matematica è la lingua di base del pensiero, ma anche perché il diritto si fonda senza scarti nella logica, da cui la matematica a sua volta ripete la propria legittimazione, essendo ormai un dato di recente acquisizione che non è la matematica che precede la logica ma il contrario.
IV
Della matematica come vocabolario del linguaggio di tutte le scienze.
L’epigrafe la potremmo dare come postulato, ma alcune notazioni possono rivelarsi anche divertenti per il lettore:
1°- la scoperta dell’importanza teorica della matematica si ritrova – per restare nel tracciato della nostra tradizione – nelle parole attribuite a Pitagora (v. Giamblico di Calcide, Summa pitagorica, tr. it., Bompiani, Milano, 2006) secondo cui “è il numero che governa le forme e le idee”;
2°- la logica matematica, come linguaggio universale dei formanti, nasce ufficialmente con Bertrand Russel e trova il suo culmine, allo stato non superato, in Ludwig Wightunstein il quale costruisce, nel Tractatus logico-philosoppiens, le proposizioni atomiche e quindi indivisibili perché non dicibili, tant’è che una sua famosa frase-atomo è che “delle cose di cui non si può parlare, si deve tacere”;
3°- Douglas R. Hofstadter analizza con un criterio unico e omogeneo la matematica, la geometria e la musica, per cui scrive questo difficile libro su Goëdel, Escher, Bach (un’eterna Ghirlanda Brillante, Adelphi, Milano, 2011), rendendosi conto che quegli “erano solo ombre proiettate in diverse direzioni da una qualche solida essenza centrale” (pag. 30);
4°- i saggi sulla giustizia di Martha C. Nussbaum nascono da una mente matematica.
5°- Walter Benjamin – homme pensée senza necessità di ulteriori qualificazioni, tale è la vastità della sua cultura – affronta il tema della logica matematica di Russel e, con una finissima analisi del linguaggio, dimostra che il concetto di segreto non esiste perché “l’apparenza del segreto resta intatta soltanto per tutto il tempo in cui la soluzione si fa attendere. In altre parole, dato che la soluzione è stabilita oggettivamente, quell’apparenza è solo soggettiva. Oggettiva è solo l’intenzione che mira al segreto e all’insolubile nella forma o nell’evento e che sarà infine delusa”. (W. Benjamin, Opere complete, VIII, Frammenti e Paralipomena, Torino, Einaudi, Ed. 2014, nella parte Filosofia del linguaggio e critica della conoscenza, fr. 8, pag. 13);
6°- Umberto Eco è altro sofisticato scrittore in chiave logica (e matematica) in quanto ha scritto molto in semeiotica e due suoi libri, che cito a caso, ruotano su ragionamenti concentrici, curati con i canoni della geometria (Il cimitero di Praga, Milano, Bompiani, 2010 e L’isola del giorno dopo, Milano, Bompiani, 1994);
7°- nella letteratura dell’ironia – non meno scientifica della scienza – vi sono due pensatori che utilizzano il metodo logico, fisico, matematico e nomotetico per spiegare le leggi del mondo:
(i) il primo, è il fisico Randall Munroe (cosa accadrebbe se [What if], Milano, Bompiani/RCS Libri, 2015) di cui non si può andare oltre, in questa sede, della prima domanda e risposta:
- cosa accadrebbe se la Terra e tutti gli oggetti terrestri
improvvisamente smettessero di girare ma l’atmosfera mantenesse la sua velocità?
- Morirebbero quasi tutti. Poi le cose diventerebbero interessanti. Etc.”;
(ii) il secondo è Arthur Block (La legge di Murphy e altri motivi per cui le cose vanno Milano; Longanesi, Ed. 2015, pag. 11) in cui, con uso sofisticatissimo della logica, trae dalla Legge fondamentale (Se qualcosa può andar male, lo farà) il corollario (starei per dire giuridico!) secondo cui “Ogni soluzione genera nuovi problemi”, e l’8°, utile sul piano dei rapporti pratici, secondo cui “I criteri sono sempre più ingegnosi delle precauzioni che si prendono per impedirgli di nuocere”.
V
Il diritto è matematica (non viceversa).
Questa proposizione – dopo quanto ho sinteticamente tentato di farmi comprendere dal lettore (opera improba, dato che non so rendermi comprensibile a me stesso) – mi appare protetta dalla categoria della evidenza. Sarebbe però tutto sterile, oltre che ridicolo, se mi fermassi alle superiori ostentazioni erudite in cui sono caduto (non però per vanagloria, bensì per autoironia).
Riprendo il discorso sul e nel Diritto, come scienza, per ripetere che il sistema delle norme è molto complesso e richiede quasi sempre uno sforzo enorme di riflessione per trovare la soluzione giusta (unica e sola) sul piano dell’ermeneutica.
Perché dico che una sola può essere la soluzione del caso? e come mai vi sono giudici che la pensano in modo difforme tra loro e che all’interno della stessa Corte di Cassazione (organo giurisdizionale supremo della nomofilachia) vi sono stati e vi sono indirizzi giurisprudenziali difformi e contrastanti?
Partirei dai dati costituiti da norme e da esperienza umana e giuridica) per ricostruire il significato solutorio non è un compito agevole: occorrono prudenza, equilibrio, saggezza e intuito; queste, accompagnate da altre qualità individuabili dal paziente lettore, portano ad una sola soluzione non foss’altro perché il sistema giuridico è governato da un valore ineludibile: la certezza del diritto. Se questo valore potesse dirsi fallace, allora tutto il sistema (concetto) precipiterebbe nell’arbitrio, nelle superficialità e nell’arroganza, precipitando nell’abisso (nel quale pur sempre ognuno può scegliere di tuffarsi a capo fitto), consapevole che l’approdo della (semplice) maggioranza dei giuristi nel baratro del caos comprometterebbe la ragion d’essere del diritto, regolante uniforme dei comportamenti dei popoli.
Qui non voglio, anzi non posso, scagliare anatemi sull’anarchia del diritto (che è una contraddizione in termine, perché l’ordinante non può ordinare alcunché), mi limito ad enunciare un’ipotesi (che per me è tesi) sull’impossibilità del sistema a subire vulnera dalla opiniones iuris tra loro non congruenti, ma presenti nell’ordinamento.
Sotto tale profilo, annetto (come tanti) un ruolo unico ed esclusivo alla Suprema Corte di Cassazione la quale fa della nomofilachia la ragione d’esistere quale organo giurisdizionale supremo.
Se indirizzi difformi vi sono, se aporie sussistono, ciò costituisce un falso problema perché la sentenza sbagliata in punto di diritto e perciò ingiusta si è chiamata fuori dall’ordinamento, ha cioè compiuto un atto rivoluzionario, di rifiuto del sistema. Perciò quelle sentenze hanno dolosamente o colposamente perduto la loro natura, non sono diritto e non possono quindi contraddirlo; sono scorie di un meteorite che si è allontanato dal sole (per usare una metafora astronomica): la stella continuerà a brillare, le scorie saranno dissolte nel nulla, loro meta naturale).
A chi prevedibilmente obietti – con sincerità d’intenti – la gravità del compito e la fallibilità del giurista, credo, si possa rispondere nel senso che il sistema giuridico, come tutti gli altri sistemi, è governato e orientato in chiave di perfettibilità, (non già di perfezione); è un concetto dunque dinamico e sempre in movimento (in avanti), in fieri, pur sempre orientato teleologicamente in vista del valore supremo della Giustizia (fiat Iustitia, pereat mundus).
A chi obietti, per altro verso, che non tutto è prevedibile (sia per la rugosità delle leggi sia per l’applicazione dell’esperienza), direi che il giurista dovrebbe rasserenarsi – come gli altri scienziati (in diversa disciplina), sentendo le parole del fisico che – a fronte dell’impossibilità di prevedere dove comparirà di nuovo un elettrone – suggerisce che “la probabilità fa capolino nel cuore della fisica, laddove sembrava tutto fosse regolato da leggi precise, univoche e inderogabili” (Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Milano, Adelphi, 2014).
A chi obietti, infine, che al giudice competono spazi (più o meno ampi) di discrezionalità, mi permetterei di segnalare che il potere discrezionale (secondo l’unanime insegnamento della Suprema Corte) non può mai trasmigrare in megalomane arbitrio, bensì essendo un saggio e prudente divisamento della quaestio secondo il modello del vir bonus dicendi peritus: per rispondere a questo modulo occorrono, prudenza, pazienza, scienza e senso di equanime giustizia, che si ritrova tecnicamente nei principi generali del diritto ricavabili anche (ma non solo) dalle norme scritte.
Mi viene in mente, per l’avvocato come per il giudice, il criterio del buon senso giuridico, che è una strada stretta, che attende sempre d’esser imboccata.
* Roberto G. Aloisio, avvocato;
Docente nel Master di Diritto Privato Europeo
Università degli Studi “La Sapienza” Roma